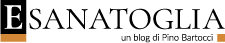Un termine che nell’odierno parlato dialettale mi sembra tenda un po’ a sparire. Ho l’impressione che una certa sua asprezza l’abbia un po’ relegato in secondo piano.
L’arbuattu, nel nostro parlato, e sembra sia cosa singolare perché in questa accezione non l’ho rinvenuta altrove, è innanzitutto il rutto (emissione rumorosa dalla bocca di aria accumulata nello stomaco), ma non quello diciamo così ‘normale’ che può uscirci accidentalmente magari liberandoci da una risultanza digestiva, tantomeno quel singulto appena accennato che, in presenza d’altri, si riesce a contenere con eleganza ricacciandolo indietro in attesa di più appropriati e discreti momenti di solitudine, ancor meno infine quello procurato assestando colpettini alla schiena dei neonati per facilitare la digestione. Diciamo che il rutto diventa arbuatto quando il rumore è particolarmente intenso e a volte, come accade per i rutti di… livello, “accompagnato anche da puzza di cibo guasto o da sapore nauseoso nella bocca” (Battaglia). Già, perché non tutti i rutti possono ambire ad entrare nella categoria degli arbuatti.
Il rutto, che il più delle volte, per addolcire il dialetto pensando di parlare correttamente in lingua, chiamiamo “rotto” (questo quando vogliamo “discoreggiare bene” come soleva ironizzare mia madre), senza che il rompere c’entri alcunché, nel dialetto esanatogliese diventa róttu o ruttu, secondo il contesto. Le origini della parola rutto, nelle sue radici primitive (RU-, RUG-) in diverse aree linguistiche, pare lo riconducano, per onomatopea, al rumore prodotto.
Per risalire invece alla spiegazione sull’origine e l’uso di arbuattu potrebbe essere una traccia quella di ricorrere alla assonanza.
Intanto diciamo che il significato di arbuattu come rutto, e quindi con una connotazione non certo positiva, nel nostro parlato viene traslato ed esteso ad indicare anche altro. Ancor più che “uomo scemo e rozzo” come pare sia secondo Amedeo Bricchi per il dialetto matelicese, siamo vicini al ” ridicolo, brutto” che Adriano Raparo suggerisce per spiegare il cognome Arbuatti, nel suo ‘Dizionario etimologico dei cognomi del Maceratese, dell’Anconetano e del Fermano‘; di più, per noi definisce, sempre in modo decisamente offensivo, una persona dall’aspetto molto sgradevole, quasi rivoltante, come se la natura avesse e-ruttato una bruttura. Una categoria dell’umano assai infima, anche se è prevista la sotto-categoria de mézzu arbuattu che per la verità potrebbe anche suonare come ‘n’arbuattu mal riuscito, quindi ancor peggiore.
Ma non sottilizziamo, ché questa categoria “de lu mezzu” si può applicare ad ogni malaparola, a qualsiasi insulto.
Attenzione però che la sgradevolezza applicata alle persone e definibile col termine di arbuattu, è quella fisica, perché chi eccelle in quella umana, comportamentale, rientra nel concetto di suàttu (ma di ciò ne parleremo, è voce a parte). Dire a una persona che è ‘n’arbuattu, significa andare molto oltre il deprezzamento associato alla definizione, ad esempio, di scòrfanu (che è semplicemente brutto, come appunto l’omonimo e sgraziato pesce), oppure di tróccu (che attiene alla forma piuttosto traccagnotta, come per l’appunto è solitamente il truogolo). La persona definita ‘n’arbuattu è un marfattu a tutto tondo, rasenta l’essere quasi vomitevole, o per lo meno che induce al conato, come appunto capita a volte con i rutti.
L’epiteto non riguarda solo le persone; il senso spregiativo si può estendere anche alle cose: ad esempio a chi capita di produrre qualcosa di pastrocchiato, uno sgorbio, un lavoro malriuscito, ma non per inezie, proprio un fiasco completo, un qualcosa che rappresenta la negazione dell’arte di quel fare, si potrebbe dire, in maniera volutamente indelicata, i fattu ‘n’arbuàttu, oppure riferendosi all’obbrobrio prodotto, ecch’è st’arbuattu?.
Non è attestato da nessuna parte. Non ho trovato tracce in documenti. Sono inoltre scarne le presenze in altri contesti dialettali.
All’epoca in cui si ragionava con Maria Letizia Di Palma (che al dialetto esanatogliese ha dedicato la sua tesi di laurea in Studi Linguistici e Filologici), sulla scia di quanto affermato dal Parrino per cui arbuatto (di cui comunque non riportava il significato di ‘rutto’) era “il bacarello, Sorbis torminalis e localmente anche corbezzolo”, s’era pensato per assonanza, proprio all’arbutus unedo, ovvero il corbezzolo detto anche àrbuto o arbùto, poiché l’ingestione dei suoi frutti, in certa quantità, può risultare indigesta e quindi provocare eruttazioni. Sembra che unedo significhi poprio che si riesce a mangiarne non più di uno (unum edere).

Altri studi invece propendono per associarlo solo all’albero detto sorbo torminale (da tormîna, diarrea): siamo comunque lì, perché anche in questo caso l’ingestione delle sue bacche causa qualche problema intestinale.

Suggestiva appare anche l’ipotesi di chi associa l’arbuatto ad una trasformazione della voce albogatto, altro nome del pioppo bianco; ma in questo caso non si capirebbe l’attinenza col rutto e con l’altra accezione negativa.
Di recente, in soccorso della ipotesi vegetale, m’è capitato di rinvenire anche una filastrocca segnalata a Pievebovigliana che conferma che stiamo parlando di un albero “[…] davanti a casa mia c’è ‘n arbuattu / lu vojo vuttà jo per facce ‘n troccu…”.
Interessante è anche la traccia che, attraverso Fabriano, ci porta addirittura in Toscana (viaggiavano le parole insieme agli uomini…). A Fabriano il rutto si dice arlotto o anche, secondo Oreste Marcoaldi (1877), arluotto; e qui qualche assonanza con arbuattu sembra esserci. Ma poi lo storico fabrianese lo fa discendere, chissà perché, dal nome di un quattrocentesco prete toscano noto per le sue burle e i suoi sberleffi, Arlotto Mainardi, detto il Pievano Arlotto.
Comunque sia, si tratta di parola riguardante un moto interno, che per convenzione sociale tendiamo a mitigare e/o reprimere quando siamo in presenza d’altri. Qualcosa per noi talmente negativo da usare il medesimo termine per bollare anche ciò che riteniamo ributtante.
Ma se vi capita di stare in solitudine, ancor meglio all’aperto e lo stomaco vi si libera espellendo una opprimente bolla d’aria che parte dalle viscere, scardina il diaframma, e che RUG-gendo esplode spandendosi nell’aere e lasciando una scia rumorosa, che potreste anche riuscire a modulare con ritmiche cadenze, sortendo una sorta di saluto al sole in piena e sfrenata libertà “a la faccia de chi ve vòle male“… beh… sappiate che avete appena fatto ‘n’arbuattu.
Un rito liberatorio, e non avete offeso nessuno.